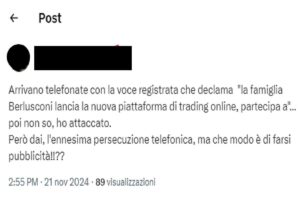Il fast fashion migliora la sostenibilità ma le certificazioni fotografano solo uno spaccato del ciclo produttivo. Qual è la realtà in atto?

Il fast fashion ha insegnato a molti ad accordare il proprio guardaroba con le passerelle; in altre parole, si può aggiornare costantemente l’armadio con le ultime tendenze dettate dalla Settimana della moda, nella primavera e nell’autunno di ogni anno. Ma dal punto di vista dei consumatori (tutti), come è stato possibile consentire di rendere una priorità il rinnovamento della propria immagine “à la mode” senza ridursi finanziariamente sul lastrico? Sono loro, le industrie che, come sempre, sono riuscite a dare una risposta pratica, produttivamente efficace.
È bastato, infatti, porre l’accento sulla qualità della catena di produzione, sull’ottimizzazione di fasi specifiche della lavorazione, esponendo le linee della moda a un processo di progettazione e di produzione economico all’insegna della rapidità. Ciò ha favorito l’acquisto dei capi da parte dei consumatori, che godono illimitatamente del basso prezzo sul cartellino in negozio. Col tempo, però, non sono mancate le critiche al sistema, accusato prima di aver contribuito gradualmente a creare condizioni di lavoro sfavorevoli nei Paesi in via di sviluppo, e poi di aver generato un drammatico impatto ambientale, dovuto all’ingente scarto (parliamo di diversi milioni di tonnellate l’anno) di rifiuti tessili.
Le aziende si sono impegnate progressivamente a calmierare il loro ciclo produttivo dotandosi di certificazioni che mettano in luce la sostenibilità delle lavorazioni; ecco, da qualche anno, la comparsa di etichette e di bollini “green” sugli abiti, frutto della collaborazione tra l’industria e gli enti certificatori, questi ultimi accreditati in più di cento nell’Ecolabel Index. Il greenwashing, vantato da diversi marchi, lascerebbe intuire i rapidi passi in avanti fatti in nome di una maggiore sostenibilità ambientale e un sistema di produzione circolare.
Nei fatti, il report “Licence to greenwash” pubblicato dalla fondazione olandese Changing markets giunge a conclusioni differenti. Essa ha raccolto un campione di dieci certificazioni selezionate tra quelle più diffuse e ne ha analizzato la condotta, sovente ostentatamente promossa, in tema di sostenibilità e di economia circolare nel settore tessile; esse rispondono al nome di: Higg Index, Oeko-Tex, Zdhc, Cradle to cradle, Ellen McArthur foundation, Weap, The microfibre consortium, Bluedesign, Eu Ecolabel, Textile Exchange.
Leggi anche: Moda e tessile, la Commissione UE guarda alla sostenibilità
Leggi anche: Uova di Pasqua, il costo umano ed ambientale del cioccolato
Sono stati presi in considerazione dieci settori che operano nella validità delle certificazioni, senza escludere l’impegno per il miglioramento continuo, l’indipendenza e la trasparenza. Delle dieci prese sotto esame, sei certificazioni deficifitano negli ambiti presi in considerazione; va meglio per Ecolabel, Bluesign, Oeko-tex e Texile exchange che ottengono valutazioni positive, ma non oltre due settori. Ecolabel (promossa dal’Ue nella Direttiva 66/2010) si è dimostrata la migliore: la sola a non avere nodi a doppio filo con gli interessi delle aziende e a esser presente sull’intero ciclo produttivo degli indumenti; se è attenta all’uso di sostanze chimiche durante la lavorazione, lo è di meno per quanto concerne l’inquinamento da microplastiche e la promozione su riuso e riciclo degli indumenti.
La generalizzata valutazione in termini negativi racconta di uno scarso aggiornamento degli obiettivi e sempre meno ambiziosi. Alcune delle certificazioni prendono in esame soltanto talune fasi del ciclo di vita dei prodotti, compreso lo smaltimento; accade perché soggette alle pressioni dei marchi che ne influenzano livello di trasparenza. Il rilascio delle stesse attestazioni dà l’opportunità alla stessa industria della moda di millantare l’innovazione e la sostenibilità dei suoi prodotti.
“La nostra analisi rivela come le certificazioni molto spesso non considerino le questioni legate alla fast fashion e alla sovrapproduzione e sembrano ignorare come il modello di business prevalente dell’industria sia uno dei maggiori responsabili per il disastro ambientale”, tuona il report. L’utilizzo di fibre sintetiche come poliestere, nylon, acrilico ed elastan, da un lato materiali estremamente economici, ma dall’altro prodotti della lavorazione di combustibili fossili, sta aggravando un impatto ambientale già pesantissimo.
Per di più anche la produzione di tessuti naturali è afflitta dall’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti scarsamente sostenibili. Ma le anomalie si riscontrano anche nell’altro lato della medaglia: in vent’anni, i consumatori hanno acquistato il doppio dei capi di vestiario e si prevede un ulteriore 63% al 2030; al contempo, la durata è quasi dimezzata, il 40% in 15 anni, e gli indumenti finiscono prima del tempo nelle discariche di tutto il mondo.
Changing markets conclude lanciando un appello alle certificazioni di sostenibilità, con la richiesta di valutare tutte le fasi della produzione secondo un approccio olistico e in una reale logica di trasparenza; ma richiama anche i consumatori a premiare, con i loro acquisti, le aziende più virtuose e a sforzarsi, in prima persona, alla pratica di comportamenti più responsabili (dei quali, l’Agenda 2030 ringrazia).